Edgar Morin, “Le 15 lezioni del corona virus. Cambiare strada”, Raffaello Cortina Editore, 2020, pp. 122, euro 11,00.
In fondo la dinamica socio-culturale che stiamo attraversando a causa del Covid-19 è semplice da comprendere: una malattia grave, contagiosissima, pandemica, sta ricordandoci con durezza che siamo uomini e, in quanto tali, siamo fragilissimi. Non siamo dei, immortali, invincibili. Malattie e morte sono elementi ineliminabili e centrali della nostra realtà. Tutto molto semplice da capire, eppure questa circostanza sta mettendo in crisi decenni, se non secoli, di culture. Come reagire? Può da sola la scienza dare risposte esaurienti? Come realizzare una nuova mappa del mondo così da difenderci e rilanciare la vita umana in una dimensione nuova e magari diversamente espansiva? È quanto sembra chiedersi il grande filosofo francese Edgard Morin nel saggio “Cambiamo strada. Le 15 lezioni del coronavirus”, Raffaello Cortina Editore (traduzione Rosella Prezzo). Lezioni che il virus ci sta impartendo con severità e che non dobbiamo perdere l’occasione di apprendere. Lezioni che riguardano ad esempio le nostre esistenze, la pervasiva incertezza esistenziale, il rapporto con la morte, il senso ultimo della nostra civiltà, la solidarietà, l’uguaglianza, la natura della crisi e ancora la realtà attuale della scienza e della medicina, le crisi dell’intelligenza, le carenze del pensiero e della politica, la crisi dell’Europa e quella del pianeta. A queste le lezioni Morin aggiunge immediatamente le sfide che si presenteranno subito dopo la fine della pandemia: l’economia da rilanciare su nuove basi, l’ecologia, il ruolo del digitale, la crisi della politica, quella della globalizzazione, quella democrazia. Occorre “cambiare strada” radicalmente, approdare a un umanesimo rigenerato che: «riconoscendo l’Homo complexus, comprende la necessità di unire ragione e passione, e che l’affettività umana può condurre all’amore o all’odio, al coraggio o alla paura; che la ragione sola e glaciale è inumana; che la tecnica può portare il meglio e il peggio; che la mente umana non cesserà di produrre miti di cui diventa schiava; che la gratuità, il gioco, le passioni fanno sì che l’interesse economico, per quanto ipertrofico nella nostra civiltà, non la fa mai del tutto da padrone».
Paolo Randazzo
Pezzo pubblicato su la Sicilia del 21 dicembre 2020.






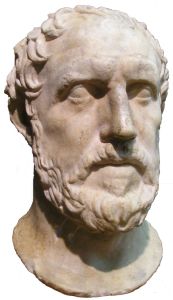


 Probabilmente non c’è più alcuno in vita dei combattenti di questa guerra ma, a parte la copiosa storiografia e la letteratura (Ungaretti, su tutti), molti italiani ne ricordano ancora oggi i racconti vivi e dolorosi fatti dai nonni, dai bisnonni, dagli anziani dei paesi e delle città. Una guerra di confini e lunghe e profonde trincee fangose, di cecchini e fanterie (povera gente, soprattutto, contadini e ragazzi di ogni parte d’Europa e d’Italia), una guerra di lunghe attese, al freddo dei ghiacciai o lasciati i soldati a marcire nel fango e sotto la pioggia. Una guerra di assalti improvvisi, assalti in cui gli uomini, solo carne da macello, venivano spinti da dietro e costretti ad avanzare dagli ufficiali (che, armi in pugno, spesso nascondevano la loro disumana ferocia e la loro vigliaccheria nelle menzogne del più bieco militarismo e della più assurda disciplina), e falciati a migliaia dalle mitragliatrici e dalle artiglierie. Una guerra di potere e menzogne, un’infame avventura pensata e voluta da minoranze fanatiche e guerrafondaie (basti pensare al turpe motto del futurista Marinetti: «la guerra sola igiene del mondo») che ben presto si rivelerà in tutta la sua tragica, miserrima, realtà. Una guerra di miseria infine, vissuta anzitutto dalle donne e dalle famiglie che restavano senza mezzi di sostentamento e poi dai reduci che, tornati alle terre d’origine, spesso storpi e sfigurati, faticavano a reinserirsi o non ci riuscivano affatto, magari col vergognoso e miserabile ben servito mensile di una pensione di “una lira e 58”. Un evento di così straordinaria e disumana violenza insomma che davvero sembra incredibile che, dopo di esso, dopo la ferita che esso ha impresso nella cultura europea, possano esserci state altre guerre, e ancora ce ne siano, che abbiano visto, e vedano, protagonisti i paesi dell’ Occidente, proprio i nostri paesi (Francia, Inghilterra, Austria-Ungheria, Serbia, Russia, Italia, Belgio e Stati Uniti). Solo “una disumana carneficina”: è giusto che questo evento oggi sia rammemorato e che, lasciata cadere ogni vuota maschera retorica e nazionalistica, sia chiamato col suo nome. A ricordarci, doverosamente, tutto questo uno spettacolo di narrazione e canti, co-prodotto dal “Biondo” di Palermo e da Promo Music (in collaborazione col Ravenna Teatro Festival) che ha debuttato in prima nazionale venerdì 13 e sarà in scena a Palermo fino a domenica 23 novembre, per iniziare subito dopo la sua lunga tournee. Teatro politico e civile, nella migliore delle accezioni, teatro popolare e, in qualche modo, anche “epico” (ovvero teatro che costringe a pensare) proprio nel senso brechtiano del termine: in scena Moni Ovadia e Lucilla Galeazzi che spendono senza risparmio la loro energia d’interpreti coi giovani del coro del Conservatorio “Bellini” di Palermo e con quattro musicisti che suonano live (Paolo Rocca, Massimo Marcer, Alberto Florian Mihai, Luca Garlaschelli). Uno spettacolo che, al di là della commovente bellezza dei canti (tra tutti, la bellissima canzone “Gorizia”), al di là della potenza della narrazione, fa giustamente parlare i numeri prima di tutto: «tra il 1914 e il 1918 morirono ogni giorno sul campo di battaglia più di 2000 uomini, fino a portare il totale delle vittime a circa 8 milioni e mezzo di caduti, ai quali poi si devono aggiungere i soldati morti in seguito e le vittime civili. Si arriva perciò a scoprire che più del 50% degli uomini impegnati nel conflitto furono fatti prigionieri, feriti o uccisi. Per quanto riguarda il quadro delle perdite per classi di età, il 12% circa del totale degli uomini caduti in combattimento aveva meno di 20 anni, mentre il 60% del totale degli uccisi aveva tra i 20 e i 30 anni. Se si applicano queste stime al totale delle perdite subite dalle potenze centrali e alleate, si ottiene un totale spaventoso di quasi 4 milioni e 750.000 morti di età inferiore ai 20 anni».
Probabilmente non c’è più alcuno in vita dei combattenti di questa guerra ma, a parte la copiosa storiografia e la letteratura (Ungaretti, su tutti), molti italiani ne ricordano ancora oggi i racconti vivi e dolorosi fatti dai nonni, dai bisnonni, dagli anziani dei paesi e delle città. Una guerra di confini e lunghe e profonde trincee fangose, di cecchini e fanterie (povera gente, soprattutto, contadini e ragazzi di ogni parte d’Europa e d’Italia), una guerra di lunghe attese, al freddo dei ghiacciai o lasciati i soldati a marcire nel fango e sotto la pioggia. Una guerra di assalti improvvisi, assalti in cui gli uomini, solo carne da macello, venivano spinti da dietro e costretti ad avanzare dagli ufficiali (che, armi in pugno, spesso nascondevano la loro disumana ferocia e la loro vigliaccheria nelle menzogne del più bieco militarismo e della più assurda disciplina), e falciati a migliaia dalle mitragliatrici e dalle artiglierie. Una guerra di potere e menzogne, un’infame avventura pensata e voluta da minoranze fanatiche e guerrafondaie (basti pensare al turpe motto del futurista Marinetti: «la guerra sola igiene del mondo») che ben presto si rivelerà in tutta la sua tragica, miserrima, realtà. Una guerra di miseria infine, vissuta anzitutto dalle donne e dalle famiglie che restavano senza mezzi di sostentamento e poi dai reduci che, tornati alle terre d’origine, spesso storpi e sfigurati, faticavano a reinserirsi o non ci riuscivano affatto, magari col vergognoso e miserabile ben servito mensile di una pensione di “una lira e 58”. Un evento di così straordinaria e disumana violenza insomma che davvero sembra incredibile che, dopo di esso, dopo la ferita che esso ha impresso nella cultura europea, possano esserci state altre guerre, e ancora ce ne siano, che abbiano visto, e vedano, protagonisti i paesi dell’ Occidente, proprio i nostri paesi (Francia, Inghilterra, Austria-Ungheria, Serbia, Russia, Italia, Belgio e Stati Uniti). Solo “una disumana carneficina”: è giusto che questo evento oggi sia rammemorato e che, lasciata cadere ogni vuota maschera retorica e nazionalistica, sia chiamato col suo nome. A ricordarci, doverosamente, tutto questo uno spettacolo di narrazione e canti, co-prodotto dal “Biondo” di Palermo e da Promo Music (in collaborazione col Ravenna Teatro Festival) che ha debuttato in prima nazionale venerdì 13 e sarà in scena a Palermo fino a domenica 23 novembre, per iniziare subito dopo la sua lunga tournee. Teatro politico e civile, nella migliore delle accezioni, teatro popolare e, in qualche modo, anche “epico” (ovvero teatro che costringe a pensare) proprio nel senso brechtiano del termine: in scena Moni Ovadia e Lucilla Galeazzi che spendono senza risparmio la loro energia d’interpreti coi giovani del coro del Conservatorio “Bellini” di Palermo e con quattro musicisti che suonano live (Paolo Rocca, Massimo Marcer, Alberto Florian Mihai, Luca Garlaschelli). Uno spettacolo che, al di là della commovente bellezza dei canti (tra tutti, la bellissima canzone “Gorizia”), al di là della potenza della narrazione, fa giustamente parlare i numeri prima di tutto: «tra il 1914 e il 1918 morirono ogni giorno sul campo di battaglia più di 2000 uomini, fino a portare il totale delle vittime a circa 8 milioni e mezzo di caduti, ai quali poi si devono aggiungere i soldati morti in seguito e le vittime civili. Si arriva perciò a scoprire che più del 50% degli uomini impegnati nel conflitto furono fatti prigionieri, feriti o uccisi. Per quanto riguarda il quadro delle perdite per classi di età, il 12% circa del totale degli uomini caduti in combattimento aveva meno di 20 anni, mentre il 60% del totale degli uccisi aveva tra i 20 e i 30 anni. Se si applicano queste stime al totale delle perdite subite dalle potenze centrali e alleate, si ottiene un totale spaventoso di quasi 4 milioni e 750.000 morti di età inferiore ai 20 anni». e, al primo impatto, la Sicilia e le sue isole minori. Un fenomeno imponente, troppo spesso tragico, denso d’implicazioni di senso e i cui effetti demografici, già visibili, annunciano grandi cambiamenti sociali, politici e culturali. Disinteressarsi di un fenomeno del genere, girarsi dall’altra parte, far finta di niente, significa non aver voglia di capire come funziona il mondo (per ignoranza, pregiudizio razzista, egoismo in malafede) e però l’arte non può essere indifferente al mondo. Da questa prospettiva, al contrario, Lina Prosa, drammaturga e regista palermitana ha da sempre vista lunga e sguardo profondo: la sua ricerca ha intersecato negli anni frontiere che riguardano i segmenti più vivi, mobili e fecondi della cultura contemporanea: le migrazioni, il corpo, la diversità, la malattia. E la sua scrittura teatrale ha già avuto i riconoscimenti che merita, ma in Francia, dove è stata accolta (non per la prima volta) con una messa in scena, nella primavera scorsa, del testo “Lampedusa Beach” sulla scena parigina della Comédie Française e, sempre in questo teatro, con la realizzazione dell’intera “Trilogia del Naufragio” (oltre “Lampedusa Beach”, anche “Lampedusa Snow” e “Lampedusa Way”), presentata tra gennaio e febbraio scorsi. Detto ciò, non può che far piacere constatare che dal 21 marzo al 17 aprile e poi dal 6 al 18 maggio, “Lampedusa Beach” è stato, finalmente, in scena anche in Sicilia, a Palermo, con un nuovo spettacolo firmato dalla drammaturga, anche in veste di regista, e con l’interpretazione della giovane Elisa Lucarelli (una prova di maturità espressiva); a produrlo e ospitarlo il Teatro Biondo con un’operazione meritoria alla quale è quasi ovvio sperare che si dia seguito con la produzione degli altri due testi di questa trilogia. Lo spettacolo si dispiega come monologo: il monologo terso e tremendo di una giovane nordafricana, immigrata clandestina, di nome Shauba che affoga nel mare proprio di fronte alla costa di Lampedusa. Shauba affonda inesorabilmente e quasi paradossalmente, affoga e rievoca la sua breve esperienza di vita, i suoi affetti, i colori del suo paese, le sue speranze, le motivazioni che l’hanno indotta a fuggire dalla sua terra («non si può rimanere nel luogo in cui si nasce, se hai la certezza che in quel luogo vive pure il tuo carnefice»): il tempo di uno spasimo, pochi istanti che si dilatano ad accogliere e ricapitolare il senso di una vita, di un viaggio, di un futuro stroncato, il senso del tradimento nei suoi confronti dell’occidente “capitalista” (in cui lei era pur pronta a integrarsi). Rievoca gli istanti tremendi della sua caduta in mare Shauba, dal rovesciarsi di quel barcone zeppo di settecento immigrati, di quella carretta che si ribalta proprio mentre lei sta per esser violentata dagli scafisti, cani che s’azzuffano per il suo corpo di giovane donna come per un pezzo di carne, fino al momento in cui lei (ma il suo corpo è già un’altra cosa), stremata ed esanime, tocca il fondale. La scrittura scenica è pulita, i colori netti, non ci sono musiche (scelta davvero interessante), né ridondanze espressive che tradirebbero la tremenda semplicità dell’accadimento, quasi ogni parola respira col suo tempo esatto e la profondità che questa vicenda implica in quanto tale: si percepisce chiaramente che coincidono regista e drammaturga. Eppure, se qualcosa appesantisce questo lavoro, è proprio l’esplicitarsi della riflessione critica e apertamente politica, il ragionare sul tradimento dell’occidente e sulla sua ostile indifferenza rispetto a quanto accade nel Mediterraneo: quel che succede a Shauba, il suo corpo che affonda e diventa pasto per i pesci, è un urlo politico in sé, lacerante e durissimo, non occorrono parole per spiegarlo, per definirlo e situarlo. Se noi italiani, se noi europei non capiamo il senso di quel che accade a Shauba siamo già perduti; se il Mediterraneo si è trasformato, in questi ultimi anni soprattutto, in uno sterminato cimitero sottomarino, forse dovremmo capire davvero che questo cimitero altro non è che l’immagine reale che l’Occidente dà di sé riflettendosi nel mare. «Il mare è innocente» dice, a un certo punto dello spettacolo, Shauba ed ha ragione.
e, al primo impatto, la Sicilia e le sue isole minori. Un fenomeno imponente, troppo spesso tragico, denso d’implicazioni di senso e i cui effetti demografici, già visibili, annunciano grandi cambiamenti sociali, politici e culturali. Disinteressarsi di un fenomeno del genere, girarsi dall’altra parte, far finta di niente, significa non aver voglia di capire come funziona il mondo (per ignoranza, pregiudizio razzista, egoismo in malafede) e però l’arte non può essere indifferente al mondo. Da questa prospettiva, al contrario, Lina Prosa, drammaturga e regista palermitana ha da sempre vista lunga e sguardo profondo: la sua ricerca ha intersecato negli anni frontiere che riguardano i segmenti più vivi, mobili e fecondi della cultura contemporanea: le migrazioni, il corpo, la diversità, la malattia. E la sua scrittura teatrale ha già avuto i riconoscimenti che merita, ma in Francia, dove è stata accolta (non per la prima volta) con una messa in scena, nella primavera scorsa, del testo “Lampedusa Beach” sulla scena parigina della Comédie Française e, sempre in questo teatro, con la realizzazione dell’intera “Trilogia del Naufragio” (oltre “Lampedusa Beach”, anche “Lampedusa Snow” e “Lampedusa Way”), presentata tra gennaio e febbraio scorsi. Detto ciò, non può che far piacere constatare che dal 21 marzo al 17 aprile e poi dal 6 al 18 maggio, “Lampedusa Beach” è stato, finalmente, in scena anche in Sicilia, a Palermo, con un nuovo spettacolo firmato dalla drammaturga, anche in veste di regista, e con l’interpretazione della giovane Elisa Lucarelli (una prova di maturità espressiva); a produrlo e ospitarlo il Teatro Biondo con un’operazione meritoria alla quale è quasi ovvio sperare che si dia seguito con la produzione degli altri due testi di questa trilogia. Lo spettacolo si dispiega come monologo: il monologo terso e tremendo di una giovane nordafricana, immigrata clandestina, di nome Shauba che affoga nel mare proprio di fronte alla costa di Lampedusa. Shauba affonda inesorabilmente e quasi paradossalmente, affoga e rievoca la sua breve esperienza di vita, i suoi affetti, i colori del suo paese, le sue speranze, le motivazioni che l’hanno indotta a fuggire dalla sua terra («non si può rimanere nel luogo in cui si nasce, se hai la certezza che in quel luogo vive pure il tuo carnefice»): il tempo di uno spasimo, pochi istanti che si dilatano ad accogliere e ricapitolare il senso di una vita, di un viaggio, di un futuro stroncato, il senso del tradimento nei suoi confronti dell’occidente “capitalista” (in cui lei era pur pronta a integrarsi). Rievoca gli istanti tremendi della sua caduta in mare Shauba, dal rovesciarsi di quel barcone zeppo di settecento immigrati, di quella carretta che si ribalta proprio mentre lei sta per esser violentata dagli scafisti, cani che s’azzuffano per il suo corpo di giovane donna come per un pezzo di carne, fino al momento in cui lei (ma il suo corpo è già un’altra cosa), stremata ed esanime, tocca il fondale. La scrittura scenica è pulita, i colori netti, non ci sono musiche (scelta davvero interessante), né ridondanze espressive che tradirebbero la tremenda semplicità dell’accadimento, quasi ogni parola respira col suo tempo esatto e la profondità che questa vicenda implica in quanto tale: si percepisce chiaramente che coincidono regista e drammaturga. Eppure, se qualcosa appesantisce questo lavoro, è proprio l’esplicitarsi della riflessione critica e apertamente politica, il ragionare sul tradimento dell’occidente e sulla sua ostile indifferenza rispetto a quanto accade nel Mediterraneo: quel che succede a Shauba, il suo corpo che affonda e diventa pasto per i pesci, è un urlo politico in sé, lacerante e durissimo, non occorrono parole per spiegarlo, per definirlo e situarlo. Se noi italiani, se noi europei non capiamo il senso di quel che accade a Shauba siamo già perduti; se il Mediterraneo si è trasformato, in questi ultimi anni soprattutto, in uno sterminato cimitero sottomarino, forse dovremmo capire davvero che questo cimitero altro non è che l’immagine reale che l’Occidente dà di sé riflettendosi nel mare. «Il mare è innocente» dice, a un certo punto dello spettacolo, Shauba ed ha ragione.